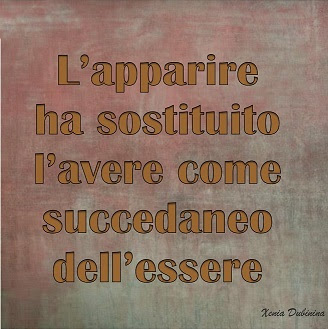“Il suo era
l’apprendistato della pazienza, il voto dell’attesa. Dal quale forse non
avrebbe più saputo liberarsi”
Ho faticato un
po’ ad entrare in sintonia con i racconti della Lispector. La narrazione in
terza persona, i periodi brevi che si limitano a descrivere comportamenti, gesti,
parole e soprattutto la costruzione paratattica che trasporta gli avvenimenti
in un eterno presente dominato da un’atmosfera di attesa e sospensione, mi
attiravano sempre più dentro alla storia, sempre più avanti nella trama e
contemporaneamente mi davano l’impressione che mi stessi perdendo qualcosa.
Perché c’è
sempre qualcosa che si è perso, che si è rotto, nei personaggi della Lispector,
qualcosa da cui discende tutto il resto.
Una raccolta
che esplora - come detto nel titolo - l’universo della famiglia, le persone per
quello che sono e per come interagiscono (o non interagiscono) tra loro. Mi
viene in mente Felici i Felici, di
Yasmina Reza: le due autrici affrontano pressappoco lo stesso argomento a
cinquant’anni di distanza, anche se con una scrittura decisamente diversa, più
compassionevole l’occhio della franco-iraniana,
decisamente più “crudo” il punto di vista della scrittrice (ucraino-)brasiliana.
Clarice
Lispector osserva le dinamiche familiari, vite in bilico, e ce le restituisce senza ammorbidirle, senza
provare a smussare gli angoli. Questa è la vita, – sembra volerci dire – questi
siamo noi. Specchiamoci e riflettiamo su quello che i nostri occhi vedono.
Nessuna indulgenza, nessuna assoluzione. Solo la nuda descrizione di quello che
i personaggi provano.
È un vivere
difficile, quello che si racconta nelle pagine di Legami familiari, un vivere al quale non si può sfuggire, ma solo
cercare di interpretare sforzandosi di farsi meno male possibile, agendo con
circospezione, stando perennemente sulla difensiva.
I personaggi
della Lispector vivono soprattutto dentro se stessi, consapevoli che uscire dal
guscio che si sono costruiti può rappresentare un rischio del quale non sanno
calcolare la portata, accompagnati dalle “meschinità
di una vita intima fatta di precauzioni”.
Sono racconti
che comunicano un senso di qualcosa che incombe, che rischia di succedere da un
momento all’altro. Quello che vediamo è un mare nero, con le acque ferme, ma
sotto intuiamo che c’è un agitarsi di correnti, un turbinio di emozioni e sentimenti,
che salgono e scendono senza raggiungere mai la superficie, condannate a vivere compresse.
Ecco, credo che
proprio questa “tensione” sia la cifra
di Legami familiari, una tensione che
la Lispector dimostra di maneggiare con precisione ed efficacia, esprimendola
al meglio quando descrive quell’ambivalenza affettiva dei personaggi sulla
quale si è soffermata la psicanalisi.
Qualche
esempio:
“Amava
il mondo, amava quanto era stato creato – amava con repulsione. Così come era
sempre stata affascinata dalle ostriche, con quel vago disgusto che
l’approssimarsi della verità le provocava, mettendola in guardia.”
“perché
quella bellezza estrema la disturbava. La disturbava? Era un rischio. Ma, no,
perché un rischio?, la disturbava solamente, erano un avvertimento, ma! no,
perché un avvertimento?”
“rifletté
sulla crudele necessità di amare. Rifletté sulla malignità del nostro desiderio
di essere felici. Rifletté sulla ferocia con la quale desideriamo giocare.”
“qualcosa
di simile alla felicità, non era ancora odio, ma una volontà tormentata di odio
simile a un desiderio”
Amore e odio,
paura della verità, il bello che attrae e spaventa e poi tanta solitudine, anche
questa cercata e fuggita al tempo stesso, ma alla quale i personaggi si votano
per poter sopravvivere:
“«Sono
sola al mondo! Nessuno mai mi aiuterà, nessuno mai mi vorrà bene! Sono sola al
mondo!»”
“tutto
quello che sentiva restava prigioniero dentro il suo petto, in quel petto che
sapeva solo rassegnarsi, solo sopportare, solo chiedere perdono, che sapeva
solo perdonare, che aveva imparato soltanto a possedere la dolcezza
dell’infelicità, che aveva imparato solo ad amare, amare, amare. Pensò che non
sarebbe mai riuscita a tradurre in azione quell’odio di cui era sempre stato
fatto il suo perdono.”