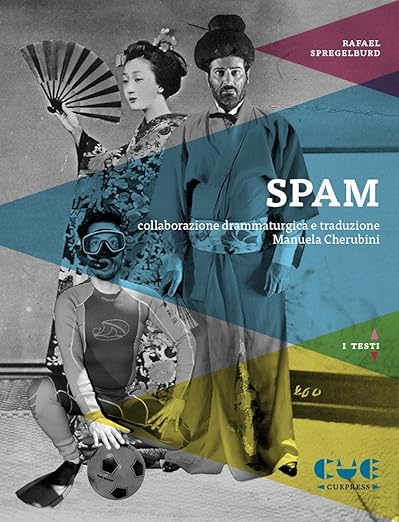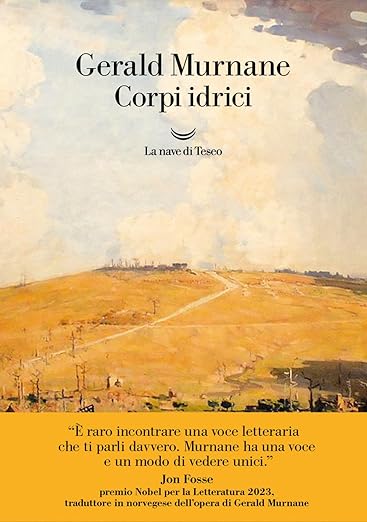Andare per restare. Un romanzo di formazione in tempi di crisi – Lorenzo Lupi
Scatole Parlanti Editore (I ed. 2025)
Come si legge un libro che parla di noi.
In Andare per restare, romanzo d’esordio di Lorenzo Lupi, seguiamo Giacomo Pasini, ragazzo che sui terrazzamenti delle Cinque Terre sogna un futuro da contadino e dialoga silenziosamente con il mare. La vendita di un bosco al centro di una speculazione edilizia offrirà alla sua famiglia l’occasione di cambiare vita e status sociale, aprendo le porte dell’università a Giacomo. Un cambio di prospettiva imprevisto che lo porterà a Milano prima e Amsterdam poi, fino ad aprirgli le porte dei santuari della finanza newyorkese. Solo dopo aver raggiunto i vertici di un successo mai cercato, Giacomo si renderà conto che non era ciò che desiderava e rifletterà su se stesso e sui propri sogni, fino a decidere di assumere finalmente il comando della propria vita.
Un libro che scorre con naturalezza, accompagnando Giacomo nei suoi spostamenti geografici e interiori, senza richiedere al lettore alcuno sforzo. A una prima lettura appare come il classico romanzo di formazione, originale per gli inserti lirici in seconda persona, scritti in corsivo, in cui l’anima del protagonista dialoga con lui secondo una modalità letteraria che ricorda il coro della tragedia greca. È solo la superficie, perché sotto l’apparenza si nasconde un romanzo generazionale anticipatorio. Giacomo Pasini è un ragazzo della “generazione 1989” che, a differenza degli altri, si mostra tiepido, se non diffidente, verso il nuovo che avanza. Chi considera la trama di un libro la parte meno interessante, un insieme di situazioni messe in fila dall’autore per far procedere la storia, e guarda più al sottotesto che al testo, troverà in Andare per restare un terreno di caccia: romanzo sulle radici, sulla crisi dopo il crollo del muro di Berlino, ma anche di riconnessione interna, che eleva la storia personale del protagonista a metafora universale della condizione umana contemporanea, offrendo al lettore una nuova prospettiva e una via per affrontare il disagio esistenziale della generazione "senza radici".









.jpg)