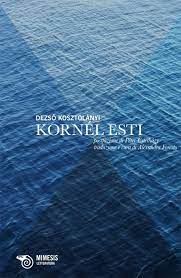Libro strano e bellissimo.
Una prosa densa, frasi lunghe e nessun 'a capo', periodi che costringono il lettore a rimanere sempre concentrato per non perdere il filo del discorso, in netta controtendenza rispetto a tanta letteratura contemporanea. Una scrittura che serve (anche) a farci entrare nel romanzo a poco a poco, con trama e personaggi che si rivelano con tempi - anche qui - più lenti rispetto a quelli a cui siamo abituati.
Krasznahorkai costruisce un romanzo sul quale incombe un'atmosfera nebbiosa e cupa che mette in dubbio le certezze fin dalla prima pagina:
...l'ordine delle abitudini non era più indiscutibile, la confusione si ramificava indomabile a sconvolgere la normale quotidianità, il futuro appariva insidioso, il passato lontano e dimenticato, mentre il normale corso delle giornate era talmente imprevedibile che la gente si era arresa...
Melancolia della resistenza è un romanzo corale, nel quale l'autore sceglie di farsi da parte e lasciare la parola ai protagonisti. La storia è raccontata da ognuno dei personaggi secondo il suo punto di vista, ognuno è chiamato a dire come si confronta con il caos che compare all'improvviso a sgretolare un ordine che si credeva immutabile.
Ed ecco scorrere sotto i nostri occhi una teoria di strategie, di comportamenti, di tecniche diverse che ognuno mette in opera per affrontare la partita con la vita.
C'è chi si difende, come la signora Pflaum:
..abituata a osservare il folle turbinio del mondo esterno dal suo benefico rifugio, e dalla considerevole distanza di quell'universo intimo tutto era così estraneo da apparire incerto, nebbioso, informe, confuso, come adesso – di nuovo seduta dietro la sicurezza, finora impeccabile di una porta chiusa a chiave, come se bastasse una serratura per dimenticare il mondo...
e chi gioca in attacco, come la signora Eszter:
...Sentendosi padrona del futuro, guardava la città con gli occhi di un'audace ereditiera, convinta di trovarsi alle soglie di “un'era radicalmente nuova, gravida di promesse, che avrebbe spazzato via tutto”...
...Il dubbio in lei non esisteva, non temeva l'imprevisto, si sentiva sicura di sé come solo lei sapeva esserlo...
...un soldato fatto e finito, che conosceva solo un ritmo, la marcia, e una sola melodia, la carica...
...Voleva che riscoprissero principi sani come la forza, l'azione, il re-a-li-smo, bisognava “spazzar via” i mercanti di illusioni, gli ingannatori, i deboli, che non volevano riconoscere la legge che ci governa: la vita è una guerra di vinti e vincitori...
...C'era un solo segreto, “non bisogna vedere a certe piccole, viscide illusioni, ma fare i conti solo con le cose concrete”. Questo era il punto più importante, “non cedere” a illusioni generalmente devastanti, come la storia che “il mondo è governato da un cosiddetto Dio, dalla morale, e naturalmente dalla bontà”, per lei il mondo degli uomini era piuttosto “un canneto di meschini interessi”, un canneto dove comanda il vento, e il vento era lei...
C'è poi chi la partita ha rinunciato a giocarla, come il signor Eszter, che si dichiara vinto e sceglie di chiudersi in casa accettando di essere stato sconfitto dalla vita e convinto del fallimento dell'umanità, dell'impossibilità di comprendere il disegno del creatore perché non esistono né disegno né creatore e l'universo è solo un alternarsi ineluttabile di distruzione e creazione, una lotta tra ciò che resiste e ciò che tenta di sconfiggere la resistenza, sul quale è inutile speculare. Un tempo aveva sperato che la musica fosse l'unica possibilità per resistere e opporsi alla “appiccicosa lordura” del mondo, ma presto aveva dovuto ammettere che anche questa era solo un'illusione, per cui aveva deciso di ritirarsi, distaccarsi, dedicarsi esclusivamente alla gioia inesprimibile della rinuncia.
E c'è anche chi ha provato a fuggire rifugiandosi nella follia, come Valuska che vive nel suo mondo di fantasia:
...navigava col pensiero e con le visioni, si muoveva libero nello spazio immenso e imperscrutabile come se quello fosse il suo vero mondo, in questo, prigioniero della sua libertà, non riusciva a trovare posto...
...il suo cervello, preda di un meravigliato stupore, era completamente scollegato dalle normali faccende terrene. Camminava “a occhi chiusi, instancabile, con l'animo perso nell'incurabile bellezza del suo cosmo personale”...
almeno fino a quando la realtà irrompe con la brutalità della violenza insensata a distruggere le fragili difese che si era costruito e lo costringe all'impasse
...poiché il paesaggio originale non c'era più sulla carta, e in quello nuovo non sarebbe stato capace di muovere un solo passo alla vecchia maniera, la cosa migliore era dimenticare tutto...
...ormai anche il “suo cuore” era morto, aveva imparato “a stare con i piedi per terra e tutto era ormai chiaro”, non credeva più che “il mondo fosse un luogo magico” …
...era uscito da un sogno malato, ma giocoso, e si era “risvegliato in un deserto” dove le cose non sono null'altro che entità tangibili...
E poi c'è la gente, la massa anonima che non capisce quello che succede e si rifugia nella superstizione e non sapendo reagire al caos si chiude in se stessa, diventando facile preda tanto per chi porta distruzione quanto per chi vuole impadronirsi del potere.
Melancolia della resistenza è un libro sulla natura e la storia dell'uomo, sulla crisi della società, sull'ignavia delle masse e sulla pericolosità dell'ambizione dei singoli, ma soprattutto un libro sul senso della vita, che racconta non tanto la lotta eroica dell'uomo nella vana ricerca di trovare una logica nell'universo, un'armonia nelle cose del mondo, quanto quello che succede dopo che l'uomo si è reso conto dell'inutilità dei suoi sforzi e si è arreso al fallimento, quando come unica forma di difesa, non gli resta altro che una resistenza passiva nei confronti della vita.


.jpg)