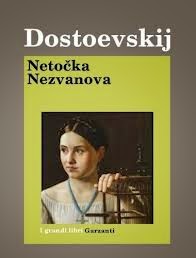Tra Leonardo e Brunelleschi
C’è uno
scienziato chino sul microscopio del suo laboratorio, intento ad osservare un
preparato. Ogni tanto regola la messa a fuoco dello strumento, cambia l’obiettivo,
sposta di pochi millimetri il vetrino. Sbuffa, si stropiccia gli occhi e poi li
alza verso il cielo. Non è soddisfatto, c’è qualcosa che manca.
Allora si alza.
Va a cercare qualcosa tra gli scaffali, apre e chiude sportelli, rovista nei
vari scomparti, poi estrae una boccetta di liquido colorato. Torna al
microscopio, inforca gli occhiali, poi con una pipetta preleva con attenzione
del liquido dal contenitore e ne lascia cadere una sola goccia sul preparato,
quindi riprende ad osservare.
Ora finalmente
va bene, e lo scienziato un po’ guarda attraverso le lenti del microscopio e un
po’ trascrive su un taccuino quello che i suoi occhi vedono.
Lo scienziato
si chiama Fëdor Dostoevskij, il preparato che sta osservando è l’umanità e la
goccia caduta sul vetrino il principe Myškin.
Una goccia importante,
una sostanza in grado di cambiare le carte in tavola, di attirarle a sé con una
forza magnetica. Una goccia che si chiama bellezza.
“L’idea
principale del romanzo è quella di rappresentare una natura umana pienamente
bella. Non c’è niente di più difficile al mondo, e specialmente oggi. Tutti gli
scrittori, non soltanto russi, ma anche tutti gli europei, che si sono accinti
alla rappresentazione di un carattere bello e allo stesso tempo positivo, hanno
sempre dovuto rinunciare. Giacché si tratta di un compito smisurato. Il bello è
un ideale, e l’ideale – sia il nostro sia quello dell’Europa civilizzata – è
ben lontano dall’essere stato elaborato.
Al
mondo c’è stato soltanto un personaggio bello e positivo, Cristo, tantoché
l’apparizione di questo personaggio smisuratamente, incommensurabilmente bello
costituisce naturalmente un miracolo senza fine. (Tutto il Vangelo di Giovanni
è concepito in questo senso: egli trova tutto il miracolo nella sola
incarnazione, nella sola apparizione del bello.) Ma mi sono spinto troppo
lontano. Dirò soltanto che tra tutti i personaggi umanamente belli della
letteratura cristiana il più completo e perfetto è Don Chisciotte. Ma Don
Chisciotte è bello unicamente perché è allo stesso tempo ridicolo.”
Così
scrive l’autore in una lettera alla nipote Sofja Aleksandrovna Ivanova, datata
gennaio 1868.
L’Idiota
è quindi un grande romanzo sulla Bellezza: quella bellezza che attrae e
respinge, troppo grande, troppo potente, troppo ingombrante per poter essere
compresa davvero, Bellezza simile a un veliero sul quale ci si può imbarcare ma
che non possiamo pensare di governare.
E
il principe Myškin incarna questa bellezza. Un essere diverso da tutti gli
altri, che vive in un mondo suo, dove le classi sociali, le convenzioni, il
denaro non hanno nessuna importanza. Un uomo buono, sensibile, onesto, incapace
di mentire, che agisce senza fare calcoli, che vede la bontà e la buona fede in
tutti, che è attirato dalla sofferenza e che ama il suo peggior nemico. Un uomo
che considera la compassione “la più
importante e forse l'unica legge di vita di tutta l'umanità” al punto da
portarla fino alle estreme conseguenze e che ha il dono di leggere nell’animo
di quella gente che vorrebbe aiutare a vivere meglio (“scusate, principe, - dice ad un certo punto uno dei personaggi del
romanzo - ma voi siete di una semplicità,
di un'innocenza che neanche nell'età dell'oro, e nello stesso tempo, tutt'a un
tratto, con una profondissima penetrazione psicologica, trapassate la gente da parte
a parte, come una freccia”). Un uomo che in un mondo come il nostro è inesorabilmente
destinato a soccombere.
Questo
per quanto riguarda il contenuto. Da un punto di vista formale possiamo
osservare come nell’Idiota si
realizzi alla perfezione quella polifonia di cui parla Bachitn a proposito del
romanzo dostoevskijano: Parfen Rogožin, Ganja Ardalionovic, Kolja, Ippolit e
soprattutto Aglaja Epančina e Nastas’ja Filippovna… la personalità di ogni
personaggio emerge attraverso dialoghi e interazioni che permettono di
caratterizzarli in maniera compiuta.
Due
paragoni mi ha fatto venire in mente la lettura dell’Idiota: quello tra la polifonia nella storia del romanzo e l’invenzione
della prospettiva nella storia dell’arte, e quello tra lo “sfumato” leonardesco
e l’attenzione che Dostoevskij dedica ai dettagli, alle contraddizioni, ai “doppi pensieri”, alla passione, al
contrasto verità/bellezza, alle nuances dell’amore, alle mille pieghe dell’animo
umano.






.jpg)